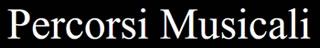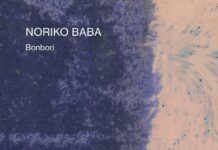Sconfortanti segnali arrivano in questi giorni da Agrigento, città italiana prescelta come capitale italiana della cultura per il 2025. La sua candidatura (come quelle precedenti e successive) è stata valutata da una giuria insediata presso il Ministero della Cultura, una commissione di 7 esperti indipendenti del mondo della cultura, delle arti e della valorizzazione territoriale e turistica, che ne ha decretato entusiasticamente la vittoria su tante altre città, ma alla luce degli eventi svoltisi in questi giorni (tra il 27 aprile e il 3 maggio appena passato) non ci si può ritenere contenti di come sono andate le cose. La stampa locale (1) ha riportato l’insufficiente partecipazione della cittadinanza e la mancata considerazione di un piano progettuale che prevedeva eventi musicali da svolgersi tra il Teatro Pirandello e il Teatro Efebo e per le strade e le piazze del centro storico, eventi che comunque avevano un costo per l’amministrazione comunale; la negatività delle vicende di Agrigento fa ancora più testo per il fatto che quel piano culturale prevedeva l’invito dei musicisti del Klangforum Wien, dove albergano alcuni tra i più preparati musicisti del mondo, ma i teatri sono andati a meno di metà delle capienze e per le strade, l’interazione urbana proposta è stata un flop, con pochissime persone a partecipare.
Di fronte a tutto questo, di chi sono le colpe?
C’è una premessa da fare prima di addentrarsi in un ragionamento sensato e quanto più lontano da logiche politiche e verte sul bando destinato al concorso delle capitali culturali, che è un’idea proveniente dalla considerazione europea; la giuria degli esperti deve valutare alcuni, imprescindibili elementi, che sono il possesso di un patrimonio artistico di rilievo, la capacità di porre in essere progettualità attinenti quel patrimonio per costituire attività nuove e partecipative della cittadinanza nonché attrarre ‘movimentazione’ turistica e soprattutto fornire elementi idonei per una ‘sensibilizzazione’ degli obiettivi condivisi con i cittadini che fanno parte di queste realtà culturali. Ecco, quindi, che un primo problema da discutere si trova in quest’opera di coinvolgimento: la stampa locale rifiuta di interrogarsi su questo punto, adducendo i gravi problemi sociali ed economici di Agrigento, dove manca persino l’acqua potabile. La domanda è: in presenza di criticità amministrative è logica la richiesta di partecipare ad un bando culturale di quel tipo? Qual è il ruolo della ‘cultura’ in questi casi? (compreso il caso musicale). La risposta è complessa, va analizzata alla luce di valori anche non politici: innanzitutto, è molto probabile che Agrigento abbia sofferto di un deficit informativo, con politiche di marketing degli eventi che non sono state ben calibrate sulla cittadinanza o adeguatamente promosse per via internazionale (2); se restiamo al Sud Italia e prendiamo l’esempio di Matera, capitale della cultura nel 2019, vediamo che le cose sono andate diversamente poiché la bellissima città dei Sassi era realmente un paese addormentato prima dell’esplosione di interesse indotta dalla mobilitazione europea: i dati economici e statistici contemplano il cambiamento in maniera inequivocabile con accresciute presenze nazionali ed internazionali (si parla del 50% in più), di progettualità inerente al territorio e all’economia del luogo (con nuovi posti di lavoro) e soprattutto, come detto prima, una forte sensibilizzazione dei cittadini ottenuta con politiche di marketing mirato ed efficiente (i dati parlano di circa duemila persone attivamente impegnate ogni giorno nella realizzazione degli obiettivi). In secondo luogo, per Agrigento si parla a sproposito del rapporto tra investimenti e ritorni: spendere 238.000 euro per il progetto ideato come ‘La cultura dell’ascolto’, facendo arrivare nel paese la migliore musica possibile (anche se difficile ed indigesta per coloro che ne comprendono le potenzialità), equivale al ‘nulla’ in mezzo all’oceano finanziario che si dovrebbe rendere disponibile per una rappresentanza cittadina di oltre 55.000 abitanti; un qualsiasi piano di ripartenza di un paese che è in preda a gravi problemi economici e sociali non può prescindere dalla considerazione dei suoi beni artistici, della sua storia e del modo con cui può offrire una chance di responsabilizzazione del territorio. Quando non ci sono i servizi essenziali o ancor più il denaro per far funzionare la città è necessario costruire progetti alternativi di sviluppo attingendo alla gratuità dei bandi pubblici italiani o europei, trovando le competenze giuste per affrontarli, vincerli ed intraprendere la difficile strada della ripartenza.
Quanto alla cultura e alle arti questionate (connubi tra patrimonio artistico e mondo sonoro), non si tratta di fare ragionamenti di élite con la musica contemporanea ma di svegliarsi una buona volta dal torpore provocato dall’accettazione di modelli musicali scontati e imposti dalle mode. Si deve avere il coraggio di ‘ascoltare’, si devono compiere percorsi preventivi e graduali di educazione musicale che tendano comunque verso una coerente direzione, come ci insegnò Luigi Nono durante una conversazione a teatro con i ragazzi di Milano: il grande compositore veneziano fece riflettere quei ragazzi di fronte all’impertinente domanda che chiedeva motivazioni sufficienti per ascoltare musica contemporanea e non generi più accessibili e Nono pose in evidenza l’imposizione musicale giunta dall’establishment americano che prescrive le menti e ciò che con poca significatività terminologica chiamiamo ‘gusto’ musicale. Nonostante siano passati decenni da quella considerazione di Nono, mi permetto di dire che la situazione non è affatto cambiata: avere ad Agrigento il Klangforum Wien, avere la musica di giovani talenti compositivi italiani e non, studiare tragitti immersivi o site specific nell’ambito di una politica della musica progressista, significa ottenere eccellenze e esempi disponibili sul proprio territorio, masticando aree di ricerca più che onorabili, che stimolano la comprensione di un possibile ‘inizio’, di una conversione culturale che non sia solo preda del ‘popolare’, senza distinguo. Quale elevazione culturale può arrivare nell’invitare cantanti popolarissimi che aberrano qualsiasi tipo di sperimentazione o aggiornamento delle tradizioni?: sarebbero ‘cartoline’ turistiche senza senso, fermo restando che esistono dovunque nel mondo ‘attori’ popolari che sarebbero consoni per il cambiamento di visione, ma restano nell’ombra delle calcificazioni delle opinioni sbagliate. Se si accetta un tipo di sviluppo culturale non personalizzato si farà fatica ad affrontare le responsabilità del cambiamento e, badate bene, lo standard è un problema anche per le città virtuose, perché metteranno in piedi un sistema culturale ingannevole; se ritorniamo a Matera, anche lì il rischio dell’inattendibilità esiste! Pensate al tipo di concerti, alle fiction e i documenti televisivi che sono nati, che hanno sconvolto la realtà contadina amata da Pasolini, una realtà che si proietta nell’immagine e nei clichés: è vero che sarebbe criticabile l’idea pasoliniana ma è anche vero che si cadrebbe in caso contrario in un agghiacciante contesto che non escluderebbe la musica.
Ad Agrigento, così come in tanti comuni italiani, ci sono anni di cattiva gestione dell’utilizzazione del denaro pubblico che non hanno paternità politiche ed un problema delinquenziale che non è affatto relativo. Nei fatti, qualsiasi autorità politica dovrà mettere in relazione le criminalità con il patrimonio culturale e artistico, stimolando nella gente il senso della responsabilità e sviluppando quegli anticorpi necessari per sviare le strade sbagliate. E’ molto difficile, lo so, ma si può fare!!
_______________________________
Nota:
(1) Qui e qui due articoli in chiave di denuncia dei fatti su Report Sicilia.
(2) Anche Percorsi Musicali ha ricevuto con ritardo le notizie del progetto culturale d’ascolto organizzato ad Agrigento (arrivate per mano della fonte esecutiva austriaca, peraltro).